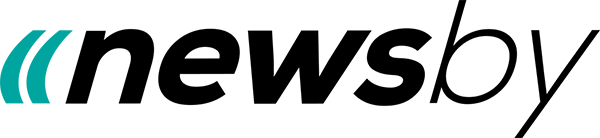Argomenti Caldi
Politica
Cronaca
Dal Mondo
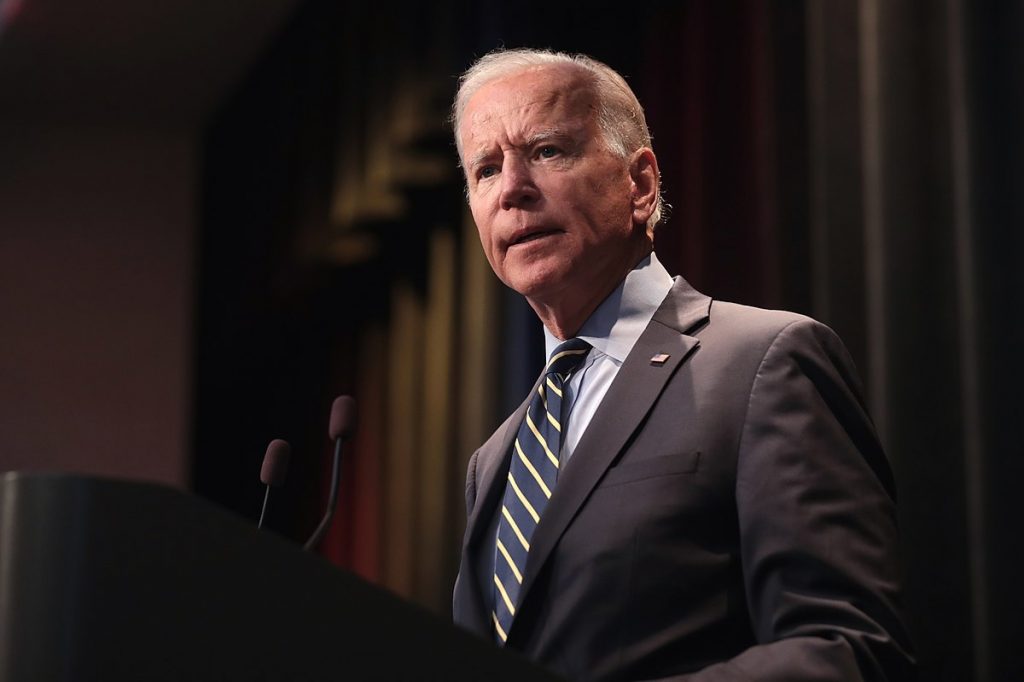
Quanti soldi hanno speso finora gli Stati Uniti per aiutare l’Ucraina?
Dopo l’approvazione del Congresso statunitense, è arrivata anche la firma di Joe Biden che conferma il pacchetto di aiuti destinato a Ucraina (e non solo), …
Ultimi pezzi
Pubblicato in
Ambiente
CambiaMenti, Pichetto Fratin: “Senza un nucleare moderno non si vada nessuna parte”