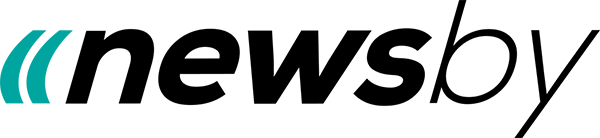Italia ’90, risolto il mistero del “tesoretto” della Nazionale di calcio
Una palla soprammobile, con sopra effigiate le 24 bandiere dei paesi partecipanti. Ne toccavi una, e via: partiva l’inno nazionale. Una raccolta di bollini reclamizzata giorno e notte col jingle “Vinci Campione!”: una chiamata alle armi per strafogarsi di glucosio, saccarosio e porcherie varie, nella sola speranza di ambire alla maglia “orange” turbo-sintetica di Ruud Gullit. Un enorme pallone di fiori, al centro del rettangolo di gioco: un colpo di plettro, e le voci rockettare del duo Nannini-Bennato inauguravano il lungo sogno delle “notti magiche”.
E’ impossibile, per chi nel 1990 era un pischello in quarta elementare come chi scrive, andare a pescare nel centrifugato di ricordi di Italia ’90. Troppi flashback gaudenti. Esagerati frame felici. Una torcida interiore impareggiabile, che tre decenni dopo si fa fatica a descrivere. Troncata da un diluvio di lacrime, dopo i due rigori sbagliati da Donadoni e Serena al San Paolo di Napoli.
Riavvolgiamo il nastro fino a Italia ’90
Gli ingredienti per un mese di sollazzo c’erano tutti. Era un’Italia abituata ad essere felice, quella lì. Lontana parente di quella incarognita e petulante di oggi. Erano gli anni del pentapartito e dei suoi sfarzi, della “Milano da bere”, della festa continua, delle pensioni elargite a man bassa dopo soli vent’anni al chiodo. Si cantava e si ballava a ogni piè sospinto: che fosse Michael Jackson, Raf o la Lambada, poco importava. Alla tv pubblica, con le sue rigidità, si affiancava ormai da qualche anno quella commerciale, tutta lustrini, paillettes, gambe nude e pubblicità.
L’iride, poi, piombava nel Belpaese in un momento in cui il pallone italico veleggiava nell’iperuranio. Milan, Sampdoria e Juventus avevano appena vinto rispettivamente Coppa Campioni, Coppa Coppe e Coppa Uefa. Il Napoli di Maradona si era cucito addosso il secondo tricolore. E ogni città aveva i suoi idoli feticcio: Firenze stravedeva per Baggio, Milano osannava i tre olandesi e i tre tedeschi sulle due sponde del Naviglio, la Genova blucerchiata impazziva per Vialli e Mancini, Napoli era tutta ai piedi del Pibe.
Il mondiale tracimava di storie incredibili. Il muro di Berlino era caduto otto mesi prima, e la Germania (poi vincitrice) si presentava unita per la prima volta dopo anni. Erano lì lì per disgregarsi invece la Jugoslavia, al via con la squadra più forte di sempre, e l’Unione Sovietica vice-campione d’Europa. La favola della Costa Rica di mister Bora Milutinovic era seconda solo a quella del Camerun che danzava gioioso al ritmo della Makossa, la rumba africana del centravanti Roger Milla. Un personaggio da romanzo, al pari del portiere colombiano Higuita, del pazzoide britannico Gascoigne e, ça va sans dire, del funambolo Totò Schillaci. Convocato per fare il luogotenente dei Vialli, Baggio, Mancini e compagnia bella, e finito con le sue pupille spiritate per diventare il simbolo dell’ebrezza estiva di un popolo.
Toda gioia, dunque, al netto di un torneo stitico di gol e spettacolo, con difese imperforabili (la nostra da urlo, tutta rossonerazzurra con Bergomi, Ferri, Baresi e Maldini) e sussulti più di grinta che di classe. Un rigore del biondo Brehme spediva la coppa in Germania, e lasciava a Roma un conto salatissimo da pagare.
Il punto a trent’anni di distanza
A distanza di trent’anni, lo si può dire con certezza: quel mondiale ci portò in alto, tanto in alto. Forse troppo: lì iniziò la picchiata. Fu lo specchio di un paese in cui tutti, ma proprio tutti, si erano abituati a vivere al di sopra delle proprie possibilità. Il conto lo paghiamo ancora oggi: quei 7 mila miliardi lire e rotti (oltre 6 mila pubblici) e quei mutui per l’impiantistica sportiva accesi con la famigerata legge quadro n.65 del 1987, generarono a loro volta aggravi su aggravi. E altri mutui, di cui ci sono tracce per milioni di euro anche nelle leggi di bilancio dei giorni nostri.
Il “Niagara” di appalti che precedette il torneo iridato è un pezzo perfetto di storia del costume italiano. In anni in cui il “tassametro” del debito pubblico saliva di minuto in minuto, non si diede troppo peso ai sovraccosti. Il comitato organizzatore fece da paravento all’agenzia pubblica che sperperò a destra e a mancina nelle infrastrutture. Dal budget iniziale, i costi lievitarono dell’85%.
Per fare cosa lo sappiamo tutti. Stadi già vetusti in sede di progettazione (il Delle Alpi di Torino), cattedrali sovradimensionate al posto sbagliato e nel momento sbagliato (il San Nicola di Bari griffato Renzo Piano), ampliamenti folli di stadi provincia (il Bentegodi a Verona e il Friuli a Udine), terzi anelli costruiti in fretta e furia (nel San Paolo di Napoli e nel Meazza di Milano). Più tutta una serie di opere accessorie, che molto spesso nulla avevano a che vedere con la logistica dell’evento. O se ne avevano, si rivelarono poi illogici ecomostri, come l’Hotel Mundial a Milano, a due passi dal parco Lambro, rimasto un rudere inguardabile per due decenni e poi abbattuto.
Quanti soldi sono andati sprecati?
Un pozzo di quattrini sprecato, dunque. Per ritrovarci nel 2020 con un parco stadi che, in base ai rilievi Fifa, ci mette persino dietro ad alcuni paesi dell’Africa. L’occasione per traghettare il paese che dominava la scena calcistica di quegli anni nel terzo millennio, si è rivelata la tomba finanziaria di un sistema che ancora oggi si porta dietro il fardello di quell’esborso delirante.
Chiariamoci: Italia ’90 fu un sogno elettrizzante. Un mese indelebile, vissuto a diversi metri da terra da tutti e al di sopra di ogni raziocino. Ci riempie il cuore ricordare le notti magiche. Il ricordo però non può prescindere dalle annesse spese tragiche. Perché quei flashback felici li stiamo ancora pagando oggi.