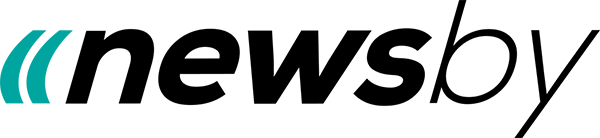This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license. Credit: Alessio Jacona
[scJWP IdVideo=”j7wNUcu7-Waf8YzTy”]
Piercamillo Davigo è stato certamente uno dei protagonisti del pool di Mani Pulite. Il 17 febbraio 1992, alle ore 17.30, Mario Chiesa viene arrestato. Esponente socialista e manager del Pio Albergo Trivulzio, il più antico e glorioso ospizio per anziani di Milano, riceve la visita di un giovane impresario di pulizie: Luca Magni. Quest’ultimo ha appena vinto un appalto e deve portargli una tangente corrispettiva. Magni è d’accordo col giudice Antonio Di Pietro che gli porterà i soldi in una valigetta: appena entrerà e consegnerà i soldi, irromperà i Carabinieri e lo prenderanno. E così avviene. Chiesa deciderà di collaborare e di fare scattare un lungo effetto dominio di confessioni di altre tangenti. Fu l’inizio di Tangentopoli. Nel giro di un anno si arrivò a 4.200 indagati. Perché successe tutto questo? “Erano finiti i soldi”, sostiene Davigo.
L’inizio di Piercamillo Davigo dentro il pool di Mani Pulite
Dottor Davigo, sono passati 30 anni da Mani Pulite: come cominciò lei personalmente quella esperienza?
«Nel mese di maggio del 1992 presi una settimana di ferie. Prima di partire, il procuratore aggiunto di Milano di allora, Gerardo D’Ambrosio, mi chiese di studiare nel frattempo alcuni verbali di questa inchiesta. Ma all’epoca avevo intenzione di cambiare funzione e di andare in Corte d’Appello e, se avessi cominciato quell’attività, sarei stato altri cinque anni in Procura. Ero già pronto a dire di non assegnare il caso a me. Se non che, ci fu la strage di Capaci. E quindi rientrai e mi misi a disposizione dell’Ufficio».
Che cosa emerse da quelle indagini?
«Le imprese che avevano rapporti prevalenti o esclusivi con la Pubblica Amministrazione avevano tutti bilanci falsi. Per cui la storia della concussione era in larga misura una bugia. Perché avevano tutti accantonato fondi neri per pagare le tangenti prima che i soldi glieli chiedessero. È come se uno, accingendosi a uscire di casa, dicesse: “Meglio che io porti dietro un po’ di soldi nel caso che mi rapinino”. Una sciocchezza enorme, a cui non si può credere. Per altro verso, la realtà era che le tangenti venivano raccolte da imprese consorziate e poi si pagava un politico che divideva con altri politici dei partiti di maggioranza e opposizione. I quali di giorno facevano finta di litigare e di notte rubavano insieme».
Perché recentemente lei ha parlato di un’occasione mancata?
«Era l’occasione per diventare più simili agli altri stati europei od occidentali in generale. Solo che l’indignazione dell’opinione pubblica passò e, nel frattempo, cominciarono le leggi per impedire i processi, come abolire i reati e azzerare le prove acquisite. Insomma: una situazione che ha mandato un chiarissimo messaggio agli imputati: Parlamento e Governo non stavano dalla parte della legge, ma da quella degli imputati. E quindi quelli che collaboravano hanno smesso di farlo».
Che cosa si sarebbe potuto fare?
«Per esempio, si poteva introdurre un meccanismo di forte riduzione di pena. Persino la non punibilità di chi collaborava. In modo da fare uscire tutto il marcio possibile subito e poi medicare la ferita. Questo perché chi collabora diventa inidoneo a commettere questi reati».
Il rapporto tra politica e giustizia durante Tangentopoli
La classe politica è riuscita a fermare le indagini?
«No. Alla fine si è creata una situazione di stallo. L’indipendenza della magistratura è complessivamente rimasta. Però sono rimaste anche le ruberie. Non c’è una stata seria diminuzione delle occasioni, ma c’è stato un calo delle condanne. Perché è più difficile scoprire le ruberie. Però, tutto sommato, le cause che hanno dato vita a quei fenomeni sono tutte là».
Quali sono?
«La prima è che i partiti sono ancora in Italia associazioni non riconosciute, all’interno delle quali succede qualsiasi cosa. Non è possibile alcun controllo del denaro che affluisce nelle casse dei partiti. Non ci sono neanche delle regole minime che ci sono in una società di persone. Poi ci sono state le leggi dissennate approvate all’epoca, poi fortunatamente abrogate e rimodificate, come quella che vanificava il delitto di false comunicazioni sociale, più nota come falso in bilancio».
Come è cambiata la corruzione
È cambiato qualcosa da allora in merito alla corruzione?
«In Italia è spaventosa: le opere pubbliche costano in media il doppio di quello che costano all’estero. E nessuno si pone il problema di fare finire questo sconcio. Con il passare degli anni c’è stata poi un’involuzione. Mentre prima almeno fingevano di dire che non si poteva fare diversamente, adesso sostengono che gli piace rubare. Quando un segretario di partito comprò all’estero una laurea al figlio con i soldi dei rimborsi elettorali, disse: “Sono soldi nostri quindi facciamo quello che vogliamo”. Per la verità sarebbero soldi dei contribuenti, non soldi loro».
Perché la percezione dell’opinione pubblica si è modificata da allora?
«Tutto cominciò nel 1993, quando il governo Amato presentò un disegno di legge che depenalizzava il finanziamento illecito ai partiti. Quello fu il primo segnale. Anche se poi rientrò, perché il Presidente della Repubblica non autorizzò la presentazione alle Camere».
Da più parti si sostiene però che il finanziamento illecito ai partiti sia sostanzialmente un reato inventato o comunque ipocrita.
«In Italia non era (e non è) vietato dare soldi ai partiti: è vietato farlo di nascosto. Questo reato è concepito in questo modo: se una società di capitali eroga un finanziamento a un partito senza deliberazione dell’organo sociale competente e senza iscriverlo a bilancio, si commette un reato punito fino a quattro anni. E lo stesso per il politico che lo riceve. Se questa legge non ci fosse stata, ci sarebbe stata o l’appropriazione indebita aggravata o il falso in bilancio. Reati tutti e due puniti più severamente. Per chi riceveva, era ricettazione: punita sempre più severamente. Il punto è che non volevano abolirla. Magari: così almeno le pene venivano aumentate. No, era quella di trasformarla in un illecito amministrativo, affidandola ai Prefetti, così non si potevano più reprimere i colpevoli».
Le accuse mosse ai magistrati di Milano
Dottor Davigo, ma è vero che voi di Mani Pulite avete abusato delle misure cautelari?
«Bugia colossale. In tutta l’indagine di Mani Pulite non c’è stato alcun provvedimento restrittivo del pubblico ministero: sono sempre stati richiesti provvedimenti al Giudice. Questi provvedimenti sono stati quasi tutti impugnati davanti al Tribunale del Riesame e alla Corte di Cassazione e sono stati tutti confermati. Siccome ci denunciavano una volta alla settima, se mai ci fosse stato qualche abuso saremmo finiti nei guai seri».
Qualcuno vi accusa in avere indotto al suicidio molti arrestati.
«Premesso che la perdita di una vita umana è sempre una tragedia e premesso anche che purtroppo nelle carceri i suicidi sono più alti rispetto all’esterno, in prigione si suicidò un solo indagato. Il quale, per quanto riguardava la nostra inchiesta, tra l’altro, era libero (Gabriele Cagliari era trattenuto in carcere da altri magistrati per una diversa indagine, quella sulla tangente Eni-Sai ndr). In generale i suicidati, alla fine sono 4 o 5, sono i migliori: nel senso che sono quelli che provavano ancora disagio per essere stati scoperti. Ci sono invece che quasi si vantavano delle cose che facevano».
Mani Pulite: Davigo e l’interrogatorio a Berlusconi
A un certo punto venne coinvolto anche Silvio Berlusconi.
«Ci fu una serie di reati, accertati indiscutibilmente. Perché anche quando scattò la prescrizione, poi ci sono stati i risarcimenti di danni. Tutto cominciò perché un vicebrigadiere, onesto e coraggioso, della Guardia di Finanza si presentò al suo superiore dicendo che il suo capopattuglia gli aveva dato dei soldi, dicendogli che venivano da Fininvest. Il suo superiore lo portò immediatamente dal comandante dell’allora nucleo regionale di Polizia tributaria e tutti e tre vennero in Procura. In poco tempo vennero arrestati cento appartenenti alla Guardia di Finanza per reati simili e, tra le altre cose, vennero fuori le tangenti Fininvest».
Ma lei ha mai conosciuto di persona Berlusconi?
«Sì, l’ho interrogato insieme al Procuratore della Repubblica e a Gherardo Colombo. L’ho avuto davanti per circa otto ore. L’interrogatorio in realtà fu molto breve, ma lui passò molto tempo a rileggere la verbalizzazione di sintesi, correggendola in continuazione, nonostante io gli avessi più volte ripetuto che tanto era integrata dalla registrazione».
Eppure lei sarebbe potuto diventare il ministro della Giustizia di un suo governo: si trattava di un’ipotesi davvero irrealizzabile?
«Intanto, io sono convinto che i magistrati non debbano fare politica, perché sono incapaci. È una forma mentis diversa. Poi non ho mai capito perché in Italia chiunque voglia fare il ministro della Giustizia, che conta poco o niente, visto che al massimo sposta al massimo i cancellieri. Era comunque probabilmente impossibile, dato il modo di ragionare dei magistrati, sedere in contesti dove si ragiona in maniera diversa».
Davigo prima di Mani Pulite: “Ci vorrebbe coraggio per fare il delinquente, non per essere onesto”
Si ricorda la sua prima indagine per corruzione? Aveva già capito come andassero le cose?
«No, così tanto no. Avevo 28 anni e interrogai il mio primo imputato per corruzione, che mi fece una certa impressione. Lui, laureato in giurisprudenza, ne aveva 27 ed era entrato in Amministrazione da pochissimo tempo e aveva già confessato al pubblico ministero di avere ricevuto una tangente di 250mila lire che gli aveva il suo diretto superiore. Rimasi colpito da una sua straordinaria normalità».
Perché?
«Era un ragazzo come me. E gli chiesi: “Ma come fa un ragazzo di 27 anni a vendersi per 250mila lire?”. Mi rispose: “Lei non può capire. Perché lei fa parte di un mondo per cui essere onesto o disonesto dipende solo da lei. Io dopo 15 giorni in cui ero là capii che tutti rubavano e che non avrebbero tollerato la presenza in mezzo a loro di un onesto, perché sarei stato un pericolo per tutti gli altri. Non ho avuto il coraggio che ci voleva per essere onesto”. Ecco, io vorrei vivere in un Paese dove ci vuole coraggio per fare il delinquente, non per essere onesto».
Riforma Cartabia: l’opinione di Davigo
Passiamo alla stretta attualità. Che cosa ne pensa della riforma del Csm?
«La degenerazione all’interno del Csm è stata nel premiare l’appartenenza piuttosto che il merito. Si tratta, secondo me, di riscrivere interamente il testo unico sulla dirigenza perché oggi non consente un trasparente esercizio della funzione decisionale del Consiglio. Dopo di che dubito che i rimedi proposti siano utili: se i magistrati venissero davvero sorteggiati sarebbero tutte monadi, che non sono nemmeno in grado di studiarsi le carte, perché non hanno abbastanza tempo per farlo. E quindi sarebbero nelle mani della struttura amministrativa. Però il sistema maggioritario, seppur temperato, non mi convince per niente, perché rischia di rafforzare le correnti più forti. Persino di avere un’unica corrente che rappresenti tutti gli eletti togati del Consiglio. E questo sarebbe devastante. Perché non tutti la pensiamo allo stesso modo».
È entrato recentemente in vigore un provvedimento che vieta ai giornalisti di fornire delle informazioni sugli indagati: lei è d’accordo?
«Io credo che la trasparenza sia un valore di per sé. La pubblicità del processo è una garanzia per sé, come dice la Corte Europei dei diritti dell’uomo. Nel divieto di comunicare c’è il rischio di lasciare spazio libero all’arbitrio: certo che non bisogna presentare l’indagato o l’imputato come colpevole, ma bisognerà pure dire i motivi per cui una persona è stata arrestata. La stampa svolge una funzione di controllo dell’operato dell’autorità. Basterebbe confrontare con quello che accade con l’attività amministrativa: salvo casi particolari, chiunque ha diritto di accesso per vedere una pratica. Più si riduce la possibilità del controllo dell’opinione pubblica sull’operato dell’autorità, anche giudiziaria, minore libertà c’è nel Paese».
L’indagine per rivelazione del segreto d’ufficio
Lei è al momento indagato per rivelazione del segreto d’ufficio per il caso Amara: non teme di finire inchiodato dai suoi detrattori per via una sua vecchia frase “Gli innocenti sono in realtà dei colpevoli che l’hanno fatta franca”? Non le potrebbe ritorcersi contro?
«Assolutamente no. Quella fu una frase detta in un contesto ben preciso. Si parlava di un processo relativo alla linea 3 della metropolitana dove l’impresa capogruppo raccoglieva denaro dalle imprese associate o consorziate e poi pagava da lì i partiti. Quindi chiunque era là dentro non poteva essere innocente per definizione. Infatti sono stati tutti condannati. E invece rappresentano quella frase come fosse un discorso generale».
Quindi non si pente di nessuna sua dichiarazione pubblica del passato? Neanche per questioni di opportunità?
«No, rifarei tutto quello che ho fatto. Perché quando ero giovane mi ero illuso che col tempo sarei diventato saggio. Invece sono diventato un po’ rimbambito (ride ndr), mentre la saggezza è sempre quella poca che avevo in gioventù. Diciamo che sono di indole guerriera, quindi appena vedo una rissa mi ci butto».